Veniamo a S. Benedetto da Norcia, nato verso il 480, <<Soli Deo placere desiderans recessit igitur, scienter nescius ac sapienter indoctus>> sull’arce di Cassino, sopra l’ara di Apollo costruisce una chiesa dedicata a San Giovanni e sul tempio di Giove ivi esistente, un’altra dedicata a San Martino da Tours.
La sua Regola fu elogiata da Gregorio Magno come vero specchio della vita del Santo e come fondamento e modello di tutto il monachesimo occidentale.
È noto che prima di lui il fenomeno del monachesimo fosse già ampiamente diffuso, fenomeno che va concatenato all’atteggiamento di disaffezione verso il mondo, immanente alla intera dottrina cristiana, con la rinnovata attesa della tanto desiderata parusìa e con gli avvenimenti storici – centrati sulla caduta dell’impero romano e sulle invasioni barbariche – che rendevano quasi certa l’instaurazione materiale del regno di Gesù Cristo su questa terra.
Da questo insieme di cause derivò il desiderio di voltare le spalle al mondo, di scuotersi di dosso i piaceri della carne, di darsi alla vita contemplativa, onde prepararsi nella materia più adeguata, sotto il profilo spirituale, a far parte della schiera degli eletti.
Benedetto ebbe il genio di opporre un nuovo tipo monachesimo, frutto di molte idee messe insieme.
Nel disordine caotico in cui si trovava l’Italia alla fine del sec.V, e più ancora durante la trentennale guerra greco-gotica che ridusse allo stremo delle forze il nostro paese, egli raccolse gli sbandati, i quali fuggivano dalle città nelle campagne dove era più facile togliersi la fame ed anche scampare alle pestilenze ed alle stragi, cercò di reintrodurre qualche forma di vita associata, tendente al ripristino dell’agricoltura, che invece era disprezzata dai barbari, i quali ammettevano solo il mestiere delle armi, e semmai qualche commercio, ma a condizione che si contrattasse fra pari, poiché l’inferiore, il vinto, poteva essere oggetto solamente di rapina; a voler essere benevoli poteva essere assoggettato ad un tributo.
Benedetto era di famiglia aristocratica: conseguentemente sapeva molto bene come si svolgesse la vita entro una villa patrizia; e, del resto – siamo alla fine del sec.V, inizi del VI secolo – ancora non si era spento il ricordo dello stile di vita delle grandi famiglie romane.
Egli si propose un ritorno ad un siffatto modo di vivere, il ritorno alla villa, nella quale accanto all’otium, (vocabolo che significa si, ozio, ma anche “svago, tempo libero, tranquillità, vita privata”; ed otiosus oltre che ozioso vuol dire anche “letterato”) si portava avanti il lavoro dei campi; era insomma la vita di studio e di lavoro piaciuta a numerosi personaggi illustri e descritta con toni più o meno poetici da Cicerone, Virgilio e Tibullo, i quali erano stati molto attratti da una simile prospettiva, che corrisponde a quella del moderno signorotto di campagna. Però – deve essersi chiesto Benedetto – il patrizio, o più semplicemente il possidente delle felici epoche imperiali irrimediabilmente tramontate, poteva disporre di torme di schiavi, obbligati a lavorare per lui la terra, mentre egli riservava il proprio tempo a coltivare le lettere e le arti: di modo che il suo pane quotidiano era più che assicurato; ma i monaci? Come avrebbero provveduto al proprio sostentamento? Ebbene, la soluzione c’era: essi avrebbero lavorato con le proprie mani; avrebbero suddiviso la giornata terrena secondo un utilizzo razionale del tempo, scandito dal suono delle campane, in un primo lasso dedicato all’ascesi, in un secondo lasso riservato al lavoro, poi al riposo e così via.
Ognuno avrebbe fatto la propria parte; nell’interesse di tutti, come in una cooperativa di produzione e di consumo, a carattere autarchico; e chi non voleva lavorare non avrebbe mangiato, come dice S.Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi (3-8,10): un grande progetto di riforma del monachesimo unita ad una visione di promozione morale e sociale.
Ecco l’origine del famoso detto “ora et labora”: sono state esigenze molto pratiche quelle che hanno determinato la vita claustrale del monaco benedettino; la Regola venne redatta dopo il 534; contiene per i monaci il divieto assoluto di possedere beni; tutte le attività devono, e nel caso del VI sec. non avrebbe potuto essere altrimenti, svolgersi all’interno del monastero, al fine di evitare il girovagare dei frati.
Un passo del Capitolo 48 espressamente dice: “Mai si trovi un fratello accidioso o che se ne stia in ozio”.
Circa il commercio, si potevano vendere i beni prodotti dal monastero, ma ad un prezzo un po’ più basso di quello corrente, al fine di non sembrare esosi.
I novizi ammessi alla vita monastica dovevano prima donare tutti i propri beni od ai poveri, oppure al monastero stesso.
Abbiamo detto che sono state esigenze pratiche quelle che hanno determinato il modo di vita benedettino. Esse, quindi, furono solo in parte condizionate da motivi ideali: questi motivi si identificarono esclusivamente con quelli religiosi.
Le conseguenze non tardarono a farsi sentire; infatti, Benedetto, nel pur minuzioso dettato della propria Regola, non aveva previsto le donazioni e le elargizioni. In breve, i monasteri, anche per l’apporto di ricchezza derivante dalla propria economia, basata su una rigida autarchia, con l’eliminazione di inutili sperperi, si trovarono possessori di enormi patrimoni immobiliari, la cui conduzione ed amministrazione era assolutamente sproporzionata rispetto alle forze dei monaci.
Fu conseguentemente necessario affidare ad affittuari la lavorazione agricola di siffatte enormi estensioni; ma da questa situazione all’astenersi dal duro, personale lavoro manuale, il passo, per i frati, fu molto breve, anzi addirittura ovvio. Si preferì di gran lunga il lavoro intellettuale, eseguibile al riparo dalle intemperie, nelle comode sale dei conventi e, come tutti sanno, simile attività si rivelò una fortuna per l’intera civiltà del passato, poiché appunto in conseguenza del processo sopra descritto si dette mano alla redazione di innumerevoli copie letterarie greche e romane, le quali in tal modo furono salvate dalla distruzione e tramandate ai posteri.
In sostanza, del famoso detto “ora et labora” il secondo termine subì un essenziale taglio; e non sempre i frati si sentirono vincolati all’obbligo di svolgere almeno un lavoro intellettuale; anzi, talvolta si dettero all’ozio totale.
Una testimonianza di quei tempi sul modo di considerare il lavoro ci proviene da Gregorio Magno: il grande papa visse non molto tempo dopo Benedetto; morì, infatti, nel 604, negli anni in cui avveniva la conversione in massa dei Longobardi al Cristianesimo: dopo di allora i monasteri respirarono, divennero luoghi abbastanza sicuri, se non fosse stato per le incursioni dei Saraceni.
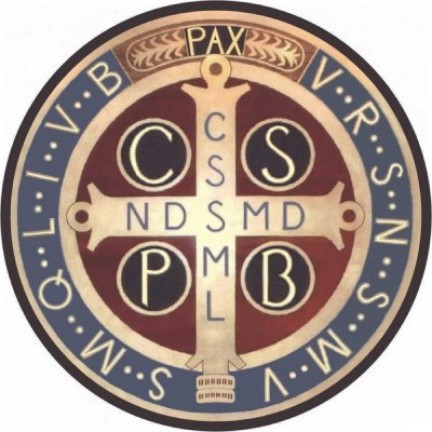

Lascia un commento